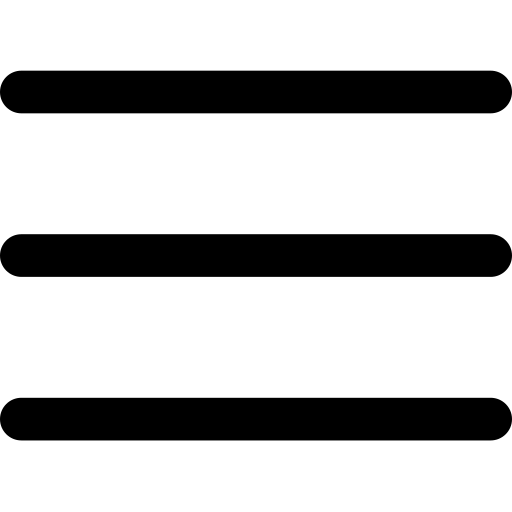Il D.lgs. 87/2024 ha aggiunto al comma 1, articolo 1, del D.lgs. 74/2000, le lettere g-quater) e g-quinquies) le quali forniscono, rispettivamente, le definizioni di crediti inesistenti e crediti non spettanti.
Il 01/07/2025 il MEF ha pubblicato l’atto di indirizzo riguardante l’attuale definizione di credito d’imposta inesistente o non spettante.
I crediti inesistenti
La lettera g-quater), aggiunta dal D.lgs. 87/2024 al comma 1, articolo 1, del D.lgs. 74/2000 definisce che “per crediti inesistenti si intendono:
- i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.”
Inoltre, occorre evidenziare che l’indicazione “e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e all’art. 54-bis del DPR 633/1972” è stata soppressa nell’attuale definizione di crediti inesistenti poiché essa, in base alla Cassazione, avrebbe limitato le ipotesi configuranti i crediti inesistenti.
Pertanto, l’attuale definizione di credito inesistente:
- è delimitata dai crediti carenti, totalmente o parzialmente, dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati dalla normativa di riferimento;
- include eventuali crediti inesistenti rilevati anche in caso di controlli automatici o formali della dichiarazione.
È possibile, quindi, comprendere fra i crediti inesistenti:
- crediti ad essi riconducibili: quelli assenti o carenti dei requisiti costitutivi del credito, come stabiliti dalle norme di riferimento, con la possibilità di riguardare il soggetto e/o l’oggetto dell’agevolazione;
- il credito inesistente potrebbe rivelarsi tale perché fruito da un soggetto diverso da quello stabilito dalla norma istitutiva oppure a causa della non esecuzione dell’operazione per la sua spettanza o per il mancato adempimento di specifici obblighi definiti come elementi essenziali per il sorgere del credito.
In ogni caso, la normativa a cui occorre riferirsi sono le fonti normative seguenti:
- la norma primaria istitutiva del credito d’imposta;
- le disposizioni recate da fonti secondarie, decreti ministeriali o regolamenti, esplicitamente richiamate dalla norma istitutiva e che completano o precisano i presupposti per la nascita del credito.
In caso di incertezza sull’inesistenza del credito non rilevano aggiuntive fonti di dettaglio possibili non espressamente richiamate nella norma istitutiva o nelle fonti secondarie.
In merito ai crediti fraudolenti occorre specificare che questi crediti, i quali si aggiungono a quelli inesistenti a causa della carenza dei presupposti costitutivi del credito, sono quelli aventi requisiti oggettivi e soggettivi che sono “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici”. Questa evenienza si verifica anche nei casi di credito originato artificiosamente e direttamente nel modello F24.
I crediti non spettanti
La lettera g-quinquies), aggiunta dal D.lgs. 87/2024 al comma 1, articolo 1, del D.lgs. 74/2000 definisce che “per crediti non spettanti si intendono:
- i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza”.
Le sopra citate definizioni valgono anche in tema di sanzioni tributarie non penali poiché il D.lgs. 87/2024 ha sostituito il comma 4 dell’articolo 13 del D.lgs. 471/1997 determinando che, salvo quanto previsto dal comma 4-ter del medesimo art. 13, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall’art. 1, co. 1, lett. g-quater) e g-quinquies) del D.lgs. 74/2000.
Pertanto, è possibile affermare che i crediti non spettanti sono:
- crediti utilizzati in difetto degli adempimenti amministrativi chiaramente stabiliti a pena di decadenza;
- crediti per i quali sussistono i requisiti indicati nella disciplina normativa di riferimento ma che sono comprovati da eventi non rientranti nella disciplina attributiva del credito per carenza di aggiuntivi elementi o peculiari qualità necessari al fine del riconoscimento del credito. Questa tipologia è attinente ai crediti d’imposta sovvenzionali, per esempio, i crediti per le attività di R&S, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica; tale classificazione ha generato le maggiori criticità interpretative e applicative;
- crediti fruiti in violazione del regolamento di utilizzo previsto dalle leggi ovvero quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle suddette norme di riferimento;
Il regolamento di utilizzo può riferirsi agli elementi indicati di seguito:
- i tempi di utilizzo del credito, per esempio, il caso di un credito da ripartite in più anni che invece viene utilizzato in un solo anno;
- la probabilità o meno di compensazione in funzione del tipo di debito da estinguere, per esempio il credito d’imposta derivante dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, co. 1, del D.L. 34/2020, adoperato da banche o intermediari finanziari in compensazione di debiti previdenziali e assistenziali, violando il divieto previsto dall’art. 4-bis, co. 1, del D.L. 39/2024;
- il caso in cui il credito non è stato utilizzato in compensazione bensì è stato oggetto di cessione o il caso in cui sia fruito oltre i limiti di compensazione di cui agli artt. 1, co. 53, della L. 244/2007, e 34 della L. 388/2000.
Con riferimento al caso particolare crediti d’imposta sovvenzionali relativi alla certificazione del bonus ricerca, sviluppo e innovazione disciplinato dal D.L. 73/2022, art. 23, co. 2 e 4, essi mirano a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa, delle normative previste dall’art. 1, c. 200, 201 e 202 e dalla L. 160/2019: a tal fine, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualifica degli investimenti eseguiti o da eseguire per consentire la loro classificazione nell’ambito delle attività di R&S, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;
La richiesta della certificazione è necessaria per i seguenti fini:
- per l’attestazione della qualificazione delle attività di R&S ai sensi dell’art. 3 del D.L. 145/2013;
- per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica rivolte all’ottenimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica con lo scopo dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal 4° periodo del comma 203, e inoltre dai comma 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;
Il requisito per la richiesta delle certificazioni è che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, previsti dalle suddette norme, nei medesimi periodi non siano state già constatate con PVC;
La certificazione determina, ferme restando le attività di controllo di cui al comma 207 del citato art. 1, alcuni effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria eccetto il caso in cui, sulla base di una errata riproduzione degli eventi, la certificazione sia emessa per una attività diversa da quella effettivamente concretizzata.
Ad eccezione dei casi particolari sopra esposti, sono nulli gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, diversi da quanto attestato nelle certificazioni.
Le sanzioni amministrative
Il D.lgs. 471/1997, all’art. 13 prevede i “Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione” e specifica nei vari commi, indicati di seguito, le relative sanzioni.
- Comma 4-bis: l’indebita compensazione di crediti non spettanti è punita, eccetto differenti disposizioni speciali, con la sanzione pari al 25% del credito adoperato in compensazione; tale sanzione si applica anche quando il credito è impiegato in difetto degli adempimenti amministrativi non previsti, a pena di decadenza, e le relative violazioni non sono state rimosse, considerando i termini stabiliti dal comma 4-ter.
- Comma 4-ter: si applica la sanzione di € 250,00 quando il credito è impiegato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di tipo strumentale, solo nel caso in cui siano rispettante entrambe le condizioni indicate di seguito: gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza e la violazione sia eliminata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi attinente all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione;
- Comma 5: si applica la sanzione pari al 70% del credito impiegato in compensazione nel caso di utilizzo di un credito per il quale scarseggino, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente precisati nella disciplina normativa di riferimento;
- Comma 5-bis: la sanzione pari al 70% è aumentata dalla metà al doppio nel caso di utilizzo di un credito i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Le sanzioni penali
L’Indebita compensazione comporta sanzioni penali previste dal D.lgs. 74/2000, art. 10-quater, come indicato di seguito.
- Comma 1: è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000. Inoltre, il co. 1 dell’art. 23 del D.L. 34/2023 ha previsto che, tra l’altro, i reati di cui all’art. 10-quater, co. 1, del D.lgs. 74/2000, non sono punibili nel caso in cui le relative violazioni sono esattamente definite e le somme dovute sono versate totalmente dal contribuente in base alle modalità e nei termini previsti dall’art. 1, co. da 153 a 158 e da 166 a 252, della L. 197/2022, purché procedure attinenti siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
- Comma 2: è punito con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute, impiegando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore a € 50.000.
- Comma 2-bis: la punibilità dell’agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, esistono condizioni di realistica incertezza relativamente a determinati elementi o alle tipiche qualità che fondano la spettanza del credito.
Il recupero dei crediti d’imposta compensati indebitamente
L’art. 38-bis del DPR 600/1973 indica le disposizioni di dettaglio sulla procedura di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti che l’Agenzia Entrate deve impiegare, in deroga alle disposizioni normalmente applicabili. Per la riscossione di crediti inesistenti e non spettanti indebitamente compensati, l’Agenzia Entrate emana un determinato atto di recupero da notificare, a pena di decadenza:
- in caso di crediti non spettanti, entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello del relativo utilizzo;
- in caso di crediti inesistenti, entro il 31/12 dell’8° anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Dott.ssa Milena Barreca
TAG crediticrediti inesistenticrediti non spettanti