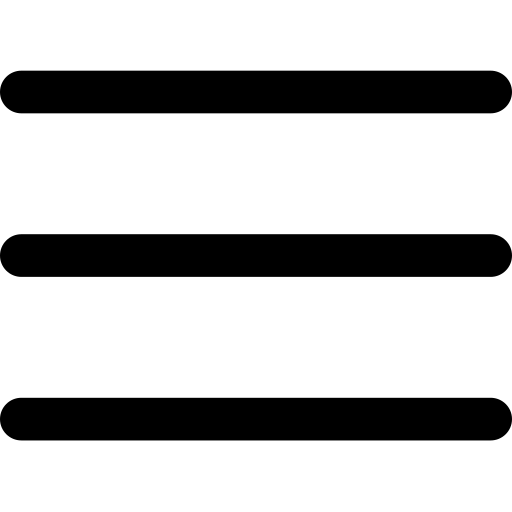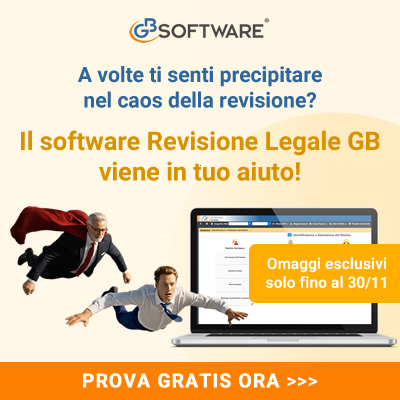La legge di bilancio 2026 introduce un profondo giro di vite sulle compensazioni orizzontali dei crediti d’imposta. Dal 1° luglio 2026 sarà vietato compensare i crediti non dichiarativi con debiti INPS e INAIL, mentre dal 1° gennaio scatta la soglia ridotta dei ruoli a 50.000 euro. Una riforma che mira a rafforzare i controlli ma che rischia di generare effetti distorsivi per imprese e professionisti, in particolare nel settore edilizio.
Il nuovo perimetro del divieto
L’articolo 26 del disegno di legge di bilancio 2026 interviene in modo strutturale sulla compensazione orizzontale. Dal 1° luglio 2026 i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non potranno essere utilizzati, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, per pagare i debiti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 (contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la gestione separata INPS, e premi INAIL).
Il divieto opera anche sui crediti trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario, superando così l’impostazione sinora circoscritta agli operatori finanziari e ai crediti edilizi delineata dall’articolo 4-bis, del D.L. n. 39/2024, in relazione allo sconto o cessione dei crediti d’imposta disciplinati dall’articolo n. 121, del D.L. n. 34/2020.
Resta ferma la possibilità di compensare i crediti dichiarativi (IVA, IRES, IRAP, ritenute) nell’alveo ordinario dell’articolo 17 (l’analisi è condotta sul perimetro delle lettere e), f), g) del comma 2 dell’articolo 17, come risulta dalle fonti ufficiali e dalla prassi; eventuali estensioni a ritenute o imposte sostitutive potranno derivare esclusivamente dal testo definitivo della legge).
In parallelo, dal 1° gennaio 2026 si riduce da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei carichi affidati alla riscossione che preclude l’utilizzo in compensazione (articolo 37, comma 49-quinquies del D.L. n. 223/2006), imponendo alle imprese un attento presidio sugli scoperti per evitare l’“effetto serranda” in fase di invio dei modelli F24.
Effetti economici e impatto operativo
L’impianto della misura è giustificato dalla finalità di presidio antifrode e dal richiamo alla Riforma 1.12 del PNRR, ma la relazione tecnica quantifica l’impatto in un ordine di grandezza modesto (centinaia di milioni di euro a regime) rispetto agli effetti organizzativi e finanziari sulle imprese.
Sono particolarmente esposte le realtà con monte contributivo elevato e bassa base imponibile, per le quali la chiusura del canale INPS/INAIL può produrre una congestione dei crediti agevolativi e, in casi estremi, la perdita delle eccedenze non utilizzate nei termini.
L’impatto è rilevante anche per i crediti RU (Transizione 4.0, 5.0, ZES e agevolazioni analoghe), tradizionalmente fruibili solo tramite compensazione in F24, che dal 1° luglio 2026 non potranno più assorbire debiti contributivi.
Il settore edile resta il caso-scuola: sul versante IVA, il reverse charge (articolo 17, comma 6, lett. a) e a-ter, D.P.R. n. 633/1972) determina posizioni creditorie strutturali; nelle imposte dirette, le ritenute d’acconto (4% nei rapporti con i condomìni e 11% sui lavori agevolati) comprimono l’imposta dovuta, generando ulteriori eccedenze.
Molte imprese hanno, negli ultimi anni, acquisito crediti edilizi mediante le operazioni di sconto in fattura o cessione del credito previste dall’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, impostando la propria pianificazione finanziaria sulla possibilità di utilizzare tali importi in compensazione tramite modello F24. Questa strategia, sinora legittima e ampiamente diffusa, consentiva di trasformare in liquidità immediata i benefici fiscali maturati, sfruttando il flusso contributivo mensile verso INPS e INAIL come canale di assorbimento naturale dei crediti.
Con l’entrata in vigore del nuovo divieto a decorrere dal 1° luglio 2026, questa possibilità viene meno proprio nel segmento più dinamico e operativo dei versamenti periodici. Le imprese dovranno quindi riorganizzare la gestione dei crediti e adottare, già nel corso del 2025, un approccio più pianificato e prudenziale. Tale anno di transizione assume un ruolo strategico: dovrà essere impiegato per ricostruire il quadro complessivo dei crediti detenuti, distinguendo quelli dichiarativi da quelli non dichiarativi, individuandone con precisione gli orizzonti di utilizzo e le relative scadenze.
Sarà inoltre fondamentale verificare la posizione debitoria presso l’agente della riscossione, riducendo per tempo gli importi iscritti a ruolo al di sotto della nuova soglia ostativa di 50.000 euro, così da non compromettere la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti residui.
Parallelamente, le imprese e i professionisti dovranno simulare la capacità di assorbimento post-divieto, ricalibrando l’impiego dei crediti su imposte come IRES, IRAP, IVA e sulle ritenute dovute, ove compatibile.
Sul piano contrattuale, sarà opportuno rinegoziare i patti interni e le clausole di manleva nei contratti di cessione, per gestire correttamente gli effetti economici e le responsabilità connesse ai crediti non più utilizzabili nei termini originariamente previsti. Infine, occorrerà prioritizzare l’utilizzo dei crediti prossimi alla scadenza, in modo da evitare fenomeni di svalutazione contabile e prevenire tensioni di liquidità derivanti dal blocco delle compensazioni più immediate.
In sintesi, il 2025 rappresenta un vero anno di snodo operativo: un periodo in cui la conoscenza analitica dei crediti, la pianificazione fiscale integrata e la revisione dei flussi finanziari diventeranno strumenti indispensabili per assicurare la continuità e la sostenibilità delle imprese nell’imminente nuovo regime delle compensazioni.
Principi, affidamento e un possibile correttivo
Il legislatore persegue finalità di rafforzamento dei controlli, ma la decorrenza fissata sulle compensazioni effettuate dal 1° luglio 2026, indipendentemente dalla data di maturazione o acquisto del credito, solleva profili delicati di legittimo affidamento e certezza del diritto.
Si interviene, infatti, su posizioni economiche formate in buona fede alla luce della disciplina previgente, come nel caso dei crediti edilizi pluriennali.
Un correttivo coerente con i principi di proporzionalità e di tutela dell’affidamento consisterebbe nel limitare il divieto ai crediti sorti o acquistati dopo l’entrata in vigore della norma, garantendo una fase transitoria ordinata e scongiurando effetti regressivi su imprese con elevata incidenza di lavoro dipendente.
La scelta di policy, oltre al profilo del gettito, va valutata in termini di continuità aziendale e liquidità d’impresa: un equilibrio che, per i professionisti e gli operatori, richiede pianificazione anticipata, accurata documentazione e presìdi di controllo interni coerenti con l’impostazione dell’articolo 4-bis del D.L. n. 39/2024.
di Roberto Bianchi
TAG compensazioniCrediti d'ImpostaManovra 2026