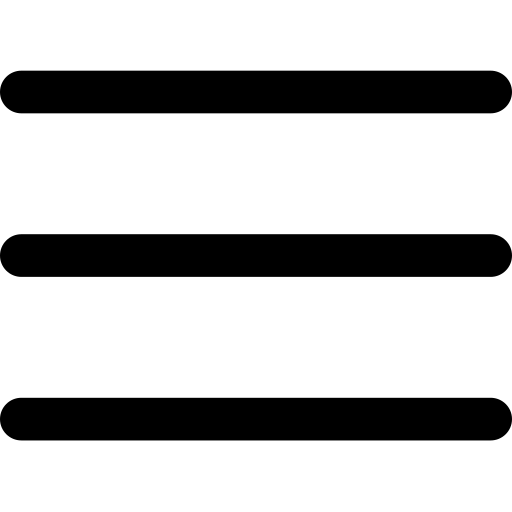Con la sentenza n. 11740/2025 la Cassazione ha ribadito che ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, ai sensi dell’art. 223, co. 2, n. 2, del RD n. 26/42 (oggi disciplinato dall’art. 329 DLgs. 14/2019) non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta anti-doverosa.
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
Ascolta “Ep.132 La rateizzazione dei debiti erariali e la bancarotta” su Spreaker.
La bancarotta impropria
Si configura la bancarotta impropria da operazioni dolose a carico dell’amministratore unico della SRL dichiarata successivamente fallita, anche se la società ha ottenuto dall’Agenzia entrate riscossione il pagamento rateale dei debiti a suo carico verso il fisco. La rateizzazione rappresenta un metodo per proseguire l’attività economica generando nuove passività, e pertanto costituisce una manipolazione di uno strumento giuridico lecito, consentendo all’amministratore della società di poter continuare a pagare dipendenti e fornitori ma non le imposte e i contributi previdenziali gravando in tal modo sull’erario le conseguenze delle proprie scelte imprenditoriali.
Sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione con la sentenza del 25 marzo 2025 n. 11740 ha ritenuto integrato nel caso esaminato l’elemento soggettivo del reato, evidenziando che l’inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, protrattosi dal 2004, era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale dell’imputato amministratore, e “che il mero pagamento rateale del debito erariale rappresentava una forma di elusione dell’inadempimento fiscale, ravvisando nel reiterato ricorso a uno strumento lecito l’intento di realizzare la diversa (illecita) finalità di ritardare la declaratoria di fallimento e di aggravare il dissesto.” In effetti, la dolosa inosservanza delle obbligazioni fiscali e previdenziali, andando ad aumentare ingiustificatamente l’esposizione della società nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali, anche in ragione dell’inevitabile carico di interessi e di sanzioni, rendeva prevedibile, proprio per l’ampiezza del fenomeno, per la sua sistematicità, e per l’entità degli importi evasi, il conseguente dissesto. Mentre l’insostenibilità del debito prodotto da tale inadempimento rendeva evidente il carattere anomalo o inadeguato, rispetto all’operazione economica intrapresa, della forma giuridica impiegata, rivelandosi l’istanza di rateizzazione una modalità di manipolazione e di alterazione dello strumento giuridico lecito.
Nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose devono porsi in nesso eziologico con il fallimento; ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l’immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l’aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società. Si tratta di reato a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, nel quale il fallimento è evento di danno, e si ritiene che la fattispecie si realizzi non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto, che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.
Inoltre la Corte di Cassazione ritiene che, poiché l’amministratore ha un obbligo di fedeltà nei confronti della società, ogni violazione di questo integra, sussistendone le altre condizioni, un’operazione dolosa ai sensi dell’art. 223 co. 2 n. 2 L. fall., che può, pertanto, consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, questo perché l'”operazione” è termine semanticamente più ampio dell'”azione”, intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l’insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano; sicché, può ben essere integrata dalla violazione – deliberata, sistematica e protratta nel tempo – dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell’esposizione debitoria della società Pertanto, considerando che, che la nozione di operazioni dolose, di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, del RD 16 marzo 1942 n. 267, prevede il comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa, l’elemento soggettivo richiesto non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato.
Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve, quindi, risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta anti-doverosa.
TAG bancarottadebitipodcast commercialisti