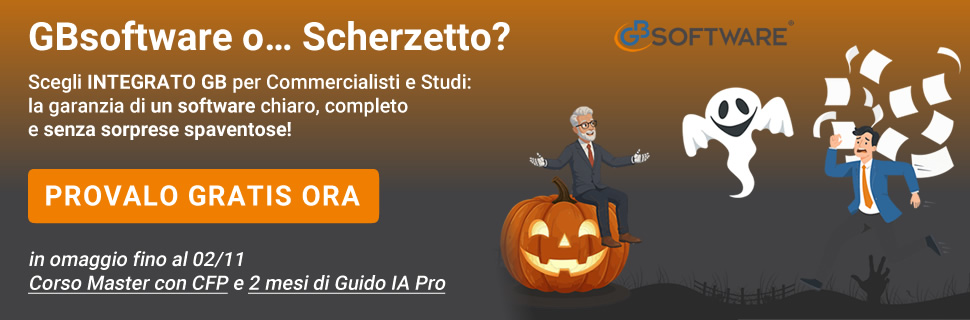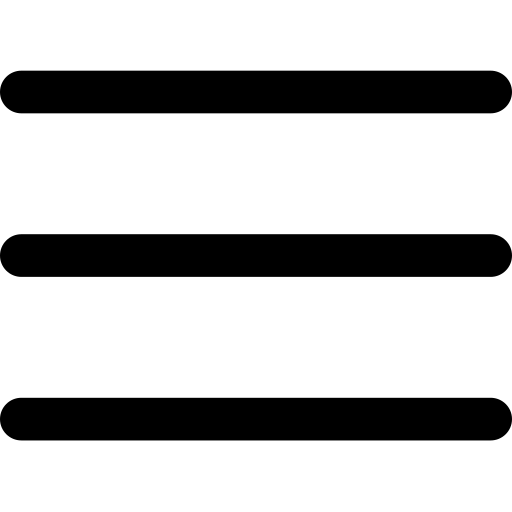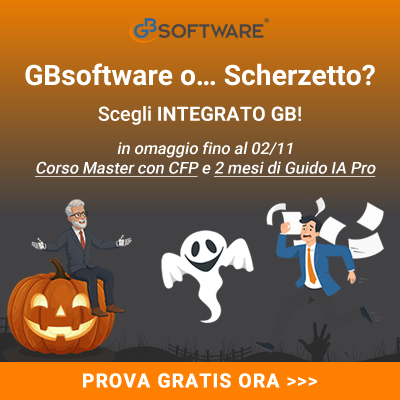Di Luciano Sorgato
La Cassazione ribadisce che le perdite su crediti causalmente raccordate ad atti transattivi sono deducibili senza la necessità di provare l’insolvenza del creditore, risultando sufficiente la prova documentale che comprovi in modo certo e preciso l’atto dispositivo sul credito
Perdite su crediti: basta la prova dell’atto transattivo
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27096/2025 ha ritenuto che le perdite su crediti derivanti da atti transattivi sono deducibili “senza limitazioni o differenziazioni in ordine alle circostanze che li determinano”. Sempre in ordine alla deducibilità di tali perdite la Cassazione ha convenuto che “non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso”.
Preliminarmente e su di un piano di ermeneutica più generale, si ritiene di dover innanzitutto sottolineare come in ordine alla perdita di un credito, il thema probandum sostanziale si raccordi ad una valutazione probabilistica e non all’esistenza di una prova certa. Nella letteratura accademica, si sottolinea come in ordine al corretto scrutinio di “elementi certi e precisi”, essi non devono apparire portatori di una prova storica, ma di una vocazione probabilistica, atta, non a radicare “una perdita documentata”, ma piuttosto a suffragare documentalmente la prova indiziaria della sufficiente probabilità della perdita del credito. La controversia interpretativa in ordine alle perdite dei crediti deve essere incapsulata, più che in una fuorviante scelta tra certezza e probabilità della perdita, nell’ individuazione di “momenti temporali”, in cui essa è sufficientemente probabile per essere tenuta in considerazione. Sino a quanto il titolo giuridico su cui si fonda il diritto di credito persiste qualsiasi valutazione sulla perdita economica del credito non può che essere ispirata a criteri di probabilità, se non altro in virtù dell’articolo 2740 del codice civile a mente del quale chi contrae un’obbligazione la garantisce con tutto il suo patrimonio presente e futuro. Gli “elementi certi e precisi” di cui all’art. 101, comma 5 del Tuir, non possono che intendersi, anche in base ai descritti rapporti di teoria generale tra probabilità e certezza, solo in senso molto relativo (R.Lupi, “Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti” in Rass. Trib. n° 5/1987), per cui, rifuggendo da rigide contrapposizioni di concetti (certezza e probabilità) solo quantitativamente diversi, il diritto di deduzione fiscale risulta correlarsi alla sola alta probabilità della perdita economica, in quanto non si tratta di dimostrare un evento, ma di conferire probabilità ad una valutazione. La certezza della perdita, quindi, consiste nello stabilire quando la probabilità della sua perdita diventi talmente elevata da assumere rilevanza ai fini della determinazione del reddito. La convenzionalità della contrapposizione tra probabilità e certezza in materia di giudizi storici è stata del resto rilevata anche in teoria generale (si veda in tal senso l’autorevole opera di CALAMANDREI, “Verità e verosimiglianza nel processo civile” in Studi sul processo civile, Padova 1957), e la linea di confine tra i due concetti è venuta gradualmente sfumando, dal momento che la certezza viene vista come una nozione convenzionale, abbinata a situazioni in cui la probabilità di una certa ipotesi è talmente elevata da far trascurare (cioè ragionevolmente escludere) le ipotesi contrarie. Già secondo la dottrina del SERACENO (“Le decisioni sul fatto incerto nel processo penale” Padova 1940) “esaminando con sincerità scientifica la certezza e il dubbio, si constata che entrambi sono fatti di probabilità e un semplice punto correlato alla scala delle probabilità divide il dubbio dalla certezza”. Si tratta di un ragionamento inferenziale tipico delle presunzioni, in quanto dalle vicende economiche del debitore, si trae, in base al fatto notorio o regola di esperienza comune, che il credito non potrà, con un’alta probabilità, essere recuperato. In tal senso risulta del tutto allineata anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2013 “un elemento di prova sicuramente utile può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive”. Rappresentato in generale il tema fiscale delle perdite su crediti va anche evidenziato che l’articolo 1, comma 160 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha apportato ulteriori aggiornamenti all’articolo 101, comma 5, del Tuir, stabilendo che “gli elementi certi e precisi” sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata in applicazione dei principi contabili. Peraltro, per i soggetti IAS adopter tale norma è meramente confermativa del principio già sancito dal D.L. n. 83/2012. L’opera di revisione della disciplina della deducibilità delle perdite va anche raccordata alla legge delega per la riforma fiscale (L. n. 23/2014), che all’articolo 12 comma 1), lett. a) prevede la introduzione di criteri chiari e coerenti con l disciplina del bilancio per determinare il momento cui connettere le perdite sui crediti. In tali complessivi aggiornamenti legislativi, mandati ad intersezione, non può non apparire come in essi riecheggi l’ormai piena coesione con il principio OIC n 15 che dispone lo stralcio contabile dal bilancio del credito non è più fondato su un titolo giuridico di supporto in virtù di atti dispositivi, tra i quali si annovera la transazione”.
TAG Deducibilità fiscalePerdite su crediti