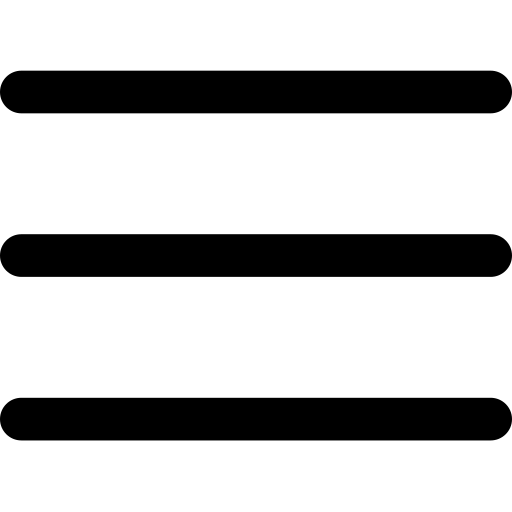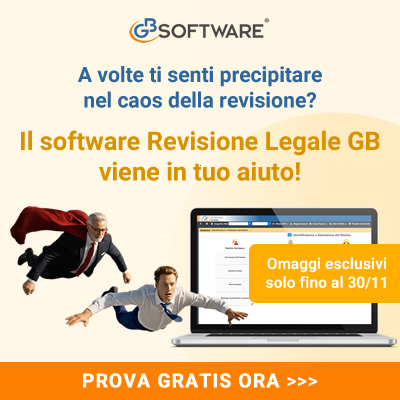IL CPB è soggetto a decadere qualora dovessero sopravvenire eventi o circostanze incompatibili con le soluzioni algoritmiche del relativo governo. Non tutte le fattispecie di decadenza appaiono però ispirate a qualificata logica ed in tale scritto si passano in rassegna alcune di esse evidenziandone gli aspetti più controversi.
Indagini su talune ipotesi di decadenza del concordato preventivo biennale
Il D.Lgs. n. 13/2024 contempla talune ipotesi di decadenza dal CPB che vengono legislativamente raccordate ad eventi ritenuti privi di “meritevolezza” ai fini della conservazione dell’istituto, con il ripristino degli ordinari poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e dell’ordinario regime fiscale di determinazione del reddito. In tale sede si passano in rassegna alcune di tali ipotesi di decadenza, con l’intento di valutarne, secondo principi di logica di diritto, le relative conseguenze.
Una prima causa di decadenza si raccorda con la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di continuare a sottoporre a controllo i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. All’Agenzia delle Entrate non è infatti precluso ogni potere di accertamento, in quanto, nonostante non riassumano alcuna rilevanza fiscale i maggiori redditi risultanti dalle scritture contabili, rimane necessario, ai fini degli stessi obiettivi sottesi allo strumento del concordato che, come noto, sono protesi a generare nei successivi bienni un allineamento tra il reddito predefinito e l’effettivo indice di capacità contributiva del contribuente, determinare il quantum effettivo del reddito conseguito. L’irrilevanza fiscale dei maggiori redditi realizzati, pur prospettando una momentanea forma di inconciliabilità costituzionale con il dovere contributivo ex articolo 53 della Costituzione, partecipa di una strategia fiscale tendente a far emergere l’evasione, allo scopo di incapsularla nelle successive commisurazioni concordatarie, trasformandola così in reddito imponibile. Questa almeno è la propulsione teorica dello strumento. La lettera a) dell’articolo 22 , comma 1, D.Lgs n. 13/2024 prevede come fattispecie di decadenza del concordato proprio una causa connessa all’accertamento, raccordandola all’emersione, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, di attività non dichiarate e dell’inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, o qualora risultino essere state commesse altre violazioni di non lieve entità secondo le indicazioni del comma 2 dell’articolo 22 in esame. Tale causa di decadenza poggia però su poteri di verifica menomati dello strumento d’indagine più efficiente nella lotta all’evasione dei contribuenti di minore dimensione economica. La preclusione delle presunzioni tipiche degli accertamenti analitico induttivi comporta la necessità per i Verificatori di deviare verso l’accertamento di illeciti fiscali fondati su prove storiche o sull’indagine basata sui fondamenti giuridici dell’inerenza, dell’antieconomicità, competenza, effettiva mancanza di supporti documentali. Rimane da verificare la possibilità del ricorso all’accertamento bancario che, come noto, secondo lo scrutinio consolidato della Corte di Cassazione, basa le sue dinamiche di verifica su presunzioni legali relative, con l’effetto di invertire l’onere della prova a carico del contribuente. Trattasi di una metodologia di accertamento molto più insidiosa delle ordinarie verifiche basate sulle presunzioni semplici sulla cui logica indiziaria il giudice tributario dispone del proprio libero convincimento. Nonostante sia possibile ritenere ed anche supportare sul piano del diritto che il paradigma del cd. “accertamento bancario” non si autonomizzi rispetto alle ordinarie metodologie accertative, nel senso che appare più consono al diritto ritenere che le presunzioni bancarie prestino solo ausilio alle ordinarie istruttorie di verifica, senza ergersi a sua volta a metodo di accertamento, la prassi lo assume da sempre come un metodo di verifica dotato di propria autonomia. Se così fosse il contribuente si troverebbe esposto a rivendicazioni reddituali ben più insidiose rispetto a quelle movibili ai contribuenti che non aderiscono al concordato e che possono talora portare alla causa di decadenza dello strumento. Inoltre, sempre in ordine a tale causa di decadenza, si deve considerare che l’entità che rileva nel calcolo dello scarto del 30% dei ricavi dichiarati, come sottolineato in Dottrina (G. Ingrao), origina un’eterogeneità di parametri rilevanti. La predetta entità costituita dalla coesione dell’emersione di attività non dichiarate e dall’indeducibilità/inesistenza di passività dichiarate va infatti confrontata non con il reddito concordato, che peraltro assume l’espressione di una sintesi reddituale di componenti positivi e negativi non analiticamente individuati, ma con i ricavi contabilizzati, e tale confronto determina il più delle volte un aumento della soglia di evasione non rilevante ai fini della decadenza. Infatti, qualora i ricavi contabilizzati siano 100 ed il reddito concordato sia 50, un complessivo illecito fiscale accertato di 25, pur sopravanzando ampiamente il 30% di 50, rimane al di sotto del 30% di 100, interdicendo la decadenza dell’istituto. Inoltre, del tutto legislativamente trascurato è la possibile contestazione in ordine alla fondatezza delle riprese fiscali operate dai Verificatori che appare verosimile possa sfociare in un rituale e contenzioso. In tale caso, allo scopo di non consentire alla Finanza arbitri di giudizio e condotte autoritative di decadenza del concordato, si deve ritenere che l’eventuale esito favorevole del contenzioso ottenuto dal contribuente, si riverberi anche sulla causa di decadenza, rimuovendola a posteriori e ripristinando l’originario reddito concordatario. L’indicata possibile mobilità del rapporto d’imposta potrebbe procurare effetti distorsivi anche in ordine ai successivi concordati biennali a cui il contribuente abbia aderito, con un poco probabile consolidamento delle relative risultanze, salvo ritenere che i successivi concordati fondati su un separato accordo, non risentano della sopravvenuta modifica dei dati di riferimento a seguito della chiusura del contenzioso. In tal caso, però, si deve evidenziare che una tale conclusione, anche se partecipa di una forma di semplificazione operativa dell’istituto, non dispone di alcun supporto di legge. Contigua alla commentata causa di decadenza è la successiva lettera b) la quale prevede come causa di decadenza la determinazione di un quantum diverso dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato, a seguito della modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/1998. Va premesso che, nonostante la mancanza legislativa di una qualsiasi soglia di rilevanza alla base di tale causa di decadenza, l’istruzione di prassi ha previsto anche per essa, per una sorta di giusta coerenza di sistema, la soglia del 30%, senza il superamento della quale il concordato resiste. Il motivo alla base della causa in esame risiede nello scostamento rispetto all’ originaria elaborazione del reddito causato dall’alterazione delle variabili alla base dell’algoritmo che ha generato la prima proposta concordataria, a seguito della dichiarazione integrativa. La sopravvenienza dei nuovi dati sfalsa la commisurazione del personale “indice” di capacità contributiva del contribuente, interdicendo quei criteri di misurazione del reddito, che, anche se fondati (almeno per il momento) su basi più teoriche che effettive, prospettano aderenza ad una forma d’intersezione dei dati standardizzata per tutti i contribuenti, impedendo arbitrarie discriminazioni. In altri termini, anche se la soluzione concordataria non è in grado di rivelare (almeno nei primi bienni di operatività dell’istituto, sino all’aggiustamento definitivo che dovrebbe venire favorito dall’auspicata condotta spontanea di emersione dei maggiori redditi non tassati) l’effettiva manifestazione di capacità contributiva del contribuente, l’uso uniforme di un processo determinativo del reddito concordatario fondato sulle effettive variabili economiche del contribuente, assicura la rivelazione di un reddito rispondente ad una logica comune per tutti i contribuenti. Il mutamento significativo dei dati economici, quindi, non consente il perseguimento di un impiego uniforme ed imparziale dell’algoritmo alla base del reddito concordatario imputato al contribuente e tale palese anomalia determina la causa di decadenza dell’istituto.
In ordine poi alla causa di decadenza raccordata all’omesso versamento delle somme concordatarie in virtù della lett. e dell’art 1, a mente della quale: “ e) viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 462/1997 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 36 bis, comma 3, DPR 600/73”, si ritiene di dover rappresentare come una dilatazione così indefinita della causa, senza alcun raccordo perimetrato a condotte omissive ispirate a piani volutamente perseguiti in pregiudizio del Fisco e, quindi, inclusive di omissioni di pagamento dovute a circostanze di forza maggiore, non autenticamente imputabili al contribuente, porta alla previsione di forme di reazione equivalenti sia verso comportamenti colposi/fraudolenti e sia verso comportamenti non contrassegnati da alcuna slealtà del contribuente. Viene prevista una forma di oggettivizzazione della causa che innesca una sanzione senza il supporto dell’ordinario elemento propulsivo della medesima, ossia di una condotta almeno colposa imputabile al contribuente, a cui risulta invece essere ispirato il sistema sanzionatorio tributario introdotto con il D.Lgs. 472/1997. In tale ultimo caso la caducazione di ogni effetto premiale, unitamente al ripristino degli ordinari poteri di verifica, porta a dubitare dell’etica dell’istituto, il cui primario fine appare essere quello di intentare in ogni caso la garanzia dell’introito erariale e non quello (enunciato) di perseguire l’emersione dei redditi evasi, allo scopo di arrivare progressivamente a personalizzare la carta d’identità fiscale dei contribuenti, per una commisurazione giusta dovere contributivo di ognuno di essi. In mancanza di colpa si sarebbe già dovuto considerare congrua la previsione della percezione coattiva delle somme concordatarie, in allineamento a quanto ordinariamente previsto nel caso di decadenza dall’istituto che rende sempre dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito concordato, anche se maggiore di quello effettivamente conseguito, ma senza arrivare a proclamarne la decadenza.
In tale sede si vuole ancora passare in rassegna le peculiarità della causa di fuoriuscita dal concordato a causa della contrazione del reddito (eccedente la misura del 30%) rispetto a quello concordato (articolo 19, comma 2 del D.Lgs. n. 13/2024). Le “circostanze eccezionali” devono manifestarsi dopo l’accordo concordatario, in quanto per quelli anteriori il contribuente è ammesso a darne notizia dell’esistenza all’Agenzia delle Entrate che ne deve tenere conto applicando le riduzioni dell’art 5 del Dm 14 giugno 2004. In ordine a tale causa di cessazione del concordato si ritiene di dover rappresentare come l’istituto venga gravato da insidie non ben ponderate. Premesso che, come peraltro sottolineato in dottrina, le circostanze eccezionali rappresentate nel citato articolo 19, comma 2 possono risolversi in minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti già autonomamente rilevanti nella determinazione del reddito imponibile, ammesso a discostarsi per tali componenti reddituali negative da quello concordatario, la mancata considerazione di circostanze che più che eccezionali sono da ritenersi congenite ad un’attività commerciale, come la perdita di clienti importanti, le difficoltà impreviste nell’approvvigionamento della merce o un inaspettato inasprimento della concorrenza (tutti eventi trascurati nella casistica delle circostanze enunciate nel D.M. 14 giugno 2024 attuativo del CPB, che considera unicamente la sopravvenienza di eventi calamitosi che comportano la dichiarazione dello stato di emergenza o eventi che determinano il danneggiamento dei locali d’impresa o professionali o delle scorte di magazzino (ma non dei beni strumentali), nonché la sospensione dell’attività imprenditoriale o professionale comunicata alla CCIAA o all’ordine di appartenenza, ma non di stati di malattia o di infortunio dell’imprenditore o del professionista adeguatamente comprovati) rischiano di trasformare il concordato in un istituto estremamente penalizzante e rischioso da disincentivarlo rispetto alle attese dell’Agenzia delle Entrate.
di Luciano Sorgato
TAG Concordato Preventivo BiennaleCPB