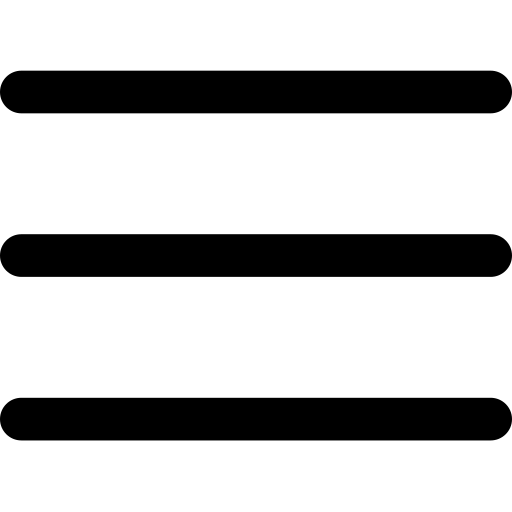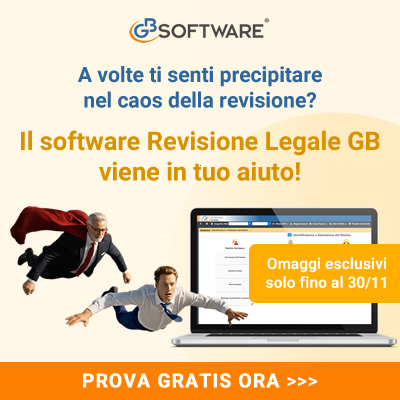L’acquisto dell’immobile strumentale da parte del professionista è investimento privo di rilevanza fiscale data l’indeducibilità delle quote di ammortamento. Diversa la situazione se lo stesso investimento viene eseguito in leasing, e da qui il tema delicato: se un professionista detiene la proprietà di un immobile può stipulare sullo stesso immobile un contratto di Lease Back, senza che l’operazione rischi di intercettare le problematiche dell’abuso del diritto? questa è la domanda a cui va data una risposta alla luce di alcuni spunti della Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione.
Il Lease Back immobiliare: un’opportunità per il professionista
Le attuali norme di cui all’articolo 54-quinquies e 54-bis del TUIR, così come modificati dal D.L. 192/2024, contengono alcuni passaggi in materia di disciplina fiscale dei leasing professionali, che appaiono di notevole interesse e, in taluni casi, di grande appeal dal punto di vista del contenimento del carico tributario gravante sull’esercente arte o professione.
Due passaggi, in modo particolare, vanno approfonditi:
- “ai fini del calcolo dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006” (articolo 54-quinquies, comma 2 del Tuir);
- “in ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato” (articolo 54-bis, comma 2 del Tuir)
Con la prima disposizione si afferma che per il professionista che sottoscrive un contratto di leasing per acquisire lo studio professionale i canoni sono deducibili (al netto del valore dell’area sottostante) in base al principio di maturazione. Questa norma, in realtà, già dal 2014 permette ai professionisti di assegnare rilevanza fiscale, e quindi deducibilità, ai canoni di leasing immobiliare, semmai l’aspetto da sottolineare è che la legge delega di Riforma Tributaria, (L. n. 111/23 , articolo 5, lettera f), punto 2.2.) aveva previsto l’eliminazione della disparità di trattamento tra indeducibilità della quota di ammortamento dell’immobile strumentale , se acquistato direttamente, e deducibilità del medesimo acquisto effettuato tramite leasing , ma , come è noto, tale disparità non è stata rimossa.
Sicchè nell’attuale scenario normativo solo l’acquisto dell’immobile strumentale tramite leasing permette di ottenere la deducibilità dell’investimento in capo al lavoratore autonomo. Tale situazione rende necessario affrontare il seguente quesito: chi detenesse già la proprietà dell’immobile professionale e non ne ricavasse alcun vantaggio fiscale (eccezion fatta per gli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007/2009 le cui quote di ammortamento sono rilevanti fiscalmente) dovrebbe, in qualche modo, trasformare la modalità diretta di detenzione del bene, in detenzione tramite locazione finanziaria. Ebbene questo obiettivo può essere raggiunto tramite l’istituto giuridico del lease back , con il quale l’immobile detenuto è ceduto ad una società di leasing la quale lo “restituisce” al professionista tramite la sottoscrizione di un contratto di leasing. In merito a tale operazione va sottolineato che l’indeducibilità delle quote di ammortamento rende non tassabile la eventuale plusvalenza conseguita, e a questa conclusione portano (oltre che alla logica) anche le Istruzioni alla compilazione del quadro RE del Modello Redditi e la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2010. Poi la sottoscrizione del contratto di leasing genera canoni deducibili, come qualunque altro leasing immobiliare stipulato dal 1° gennaio 2014, limitatamente alla “quota fabbricato” e considerando la necessità di spalmare la deduzione in almeno 12 anni, a prescindere dalla durata civilistica del contratto stesso.
Su questa operazione spesso si pone il dubbio dell’applicabilità o meno della normativa anti abuso di cui all’articolo 10-bis della L. 212/2000, considerando che ove mai venisse dichiarato l’abuso del diritto l’intera operazione verrebbe, dal punto di vista fiscale, disconosciuta.
In merito a tale aspetto si possono fare alcune considerazioni a supporto della tesi secondo cui il lease back immobiliare del professionista non integra una fattispecie di abuso del diritto.
In primo luogo, occorre osservare che il lease back immobiliare, in ambito di reddito da lavoro autonomo, non è operazione nuova alla attenzione della Agenzia delle Entrate, nel senso che in almeno due precedenti la stessa Agenzia è stata sollecitata ad esaminare questo negozio giuridico.
In primo luogo, la sopracitata risoluzione n. 13/E/2010 nella quale veniva esaminata la fattispecie di un lease back nel quale l’acquisto originario era stato eseguito dall’interpellante in veste di privato cittadino. Ciò ha portato l’Agenzia a riconoscere l’irrilevanza della plusvalenza, anche se, per contro, il contratto di leasing stipulato dopo il 2009 e prima del 2014 non portava alcun vantaggio in termini di deduzione al professionista. Ma nessun appunto in merito ad un eventuale abuso del diritto era stato eccepito in quella occasione dalla parte della A.F.
Il secondo intervento, più recente, è l’Interpello 742/2021 nel quale è stata descritta una complessa operazione posta in essere da un professionista che, in una serie concatenata di atti eseguiva anche un lease back immobiliare. La conclusione finale della Agenzia è stata svavorevole al contribuente nel senso che è stata dichiarata una operazione in abuso del diritto, ma non per contestazioni relative al contratto di lease back.
In estrema sintesi ricostruiamo la concatenazione di atti oggetto dell’interpello: un professionista proprietario dell’immobile strumentale esegue un lease back e successivamente cede il contratto di leasing ad una SRL immobiliare, per un corrispettivo decisamente inferiore al valore normale dell’immobile. Poi la SRL immobiliare loca l’immobile ad uno studio associato del quale il professionista istante è socio. L’Agenzia contesta la fattispecie di abuso del diritto nella misura in cui sia stato scelto di cedere il contratto di leasing (con un corrispettivo molto basso) in luogo di conferire il contratto stesso a valore normale, con conseguente emersione di maggiore plusvalenza. Ma nessun appunto è stato fatto sulla “trasformazione” della proprietà del bene in detenzione in qualità di utilizzatore di contratto di leasing.
Peraltro, anche sotto il profilo giurisprudenziale si possono citare esiti a favore del contribuente che negano la qualifica di operazione abusiva per il lease back. In modo particolare è interessante la sentenza n. 18333/2021 della Corte di Cassazione.
In questa sentenza si afferma che il contratto di lease back non può essere attratto alla declatoria di abuso del diritto poiché in esso è presente una ragione economica rilevante che consiste nella trasformazione in liquidità di un investimento immobilizzato con conseguente beneficio finanziario per il contribuente. In modo particolare la Suprema corte afferma: “Tale operazione, difatti, pur procurando al contribuente un risparmio d’imposta, collegato all’accelerata deducibilità della prima maxi-rata, consente di realizzare un concreto interesse, che rientra nella libertà d’iniziativa economica, sostituendo un pregresso debito bancario con un finanziamento a condizioni migliori, e non risulta, pertanto, irragionevole rispetto alle ordinarie logiche d’impresa”.
Pertanto, il lease back, che ha come oggetto l’immobile professionale, appare operazione estranea alla logica dell’abuso del diritto e quindi praticabile ottenendo quel vantaggio in termini di deduzione del canone, che viceversa non sarebbe stato conseguito.
Semmai operazione sconsigliabile, a parere di chi scrive, è quella correlata al lease back immobiliare, laddove, una volta, terminato il contratto, si pensi di trasferire la proprietà dell’immobile senza subire tassazione.
Più precisamente, lo schema contrattuale che alcuni operatori (più che altro agenti immobiliari, n.d.r.) suggeriscono è il seguente:
Viene stipulato un lease back immobiliare ottenendo la deducibilità dei canoni, al netto della quota area sottostante. Una volta portato a termine il periodo contrattuale, viene riscattato l’immobile, non procedendo ad ammortizzare il valore di riscatto, in forza della indeducibilità della quote di ammortamento relative all’acquisto dell’immobile strumentale. Iniziata la fase di indeducibilità integrale delle quote di ammortamento si procede alla cessione dell’immobile realizzando una forte plusvalenza che (gli stessi operatori che propongono il presente schema di negozi giuridici) giudicano non rilevante fiscalmente.
La conclusione di non rilevanza fiscale della plusvalenza muoverebbe proprio dall’altra novità legislativa citata in premessa, cioè la necessaria proporzionalità tra il quantum dedotto nella fase di ammortamento del cespite ed il quantum tassabile riferibile alla plusvalenza. Sicchè a fronte di quote di ammortamento (relative al prezzo di riscatto) integralmente indeducibili si avrebbe una plusvalenza integralmente non tassabile. Tutto ciò in forza del citato art. 54 bis, comma 2 del Tuir. Il ragionamento proposto poggia su una adesione letterale al testo normativo: dal momento che il riscatto dell’immobile è assimilato all’acquisto dello stesso, è come se il contribuente acquistasse un immobile (ad un corrispettivo irrisorio quale è il prezzo di riscatto) le cui quote di ammortamento sono indeducibili dal che conseguirebbe l’irrilevanza della plusvalenza in quanto correlata a costi non dedotti.
Non sfuggirà a nessuno, tuttavia, la fragilità di questa impostazione se la collochiamo su un piano sostanziale.
E’ di tutta evidenza che spostando l’attenzione dal dato meramente letterale a quello sostanziale, nel periodo in cui sono stati dedotti i canoni si è fruito di un componente negativo che dal punto di vista formale è canone, ma dal punto di vista sostanziale è costo di acquisto dell’immobile. Tale deducibilità non può essere disconosciuta in sede di calcolo della proporzione tra il costo fiscalmente rilevante e la percentuale di imponibilità della plusvalenza. Condividendo questa tesi che mette in risalto il dato sostanziale si può proporre un esempio di calcolo che, sempre chi scrive, ritiene corretto:
Costo dell’immobile 100 prezzo di riscatto 10, quota terreno 20. L’importo sostanzialmente in questo caso è 70 (10 valore di riscatto ammortizzato e quindi indeducibile, 20 quota terreno resa indeducibile direttamente nei singoli canoni). Se la plusvalenza conseguita fosse, ad esempio pari a 150, avremmo che il 70% di essa (105) è rilevante fiscalmente mentre 45 va scomputato dall’imponibile ex art. 54-bis, comma 2 del Tuir.
Questa ultima potrebbe essere una proposta razionale per gestire l’operazione lease back immobiliare/ riscatto/cessione dell’immobile.
di Paolo Meneghetti
TAG Lease BackLease Back immobiliare