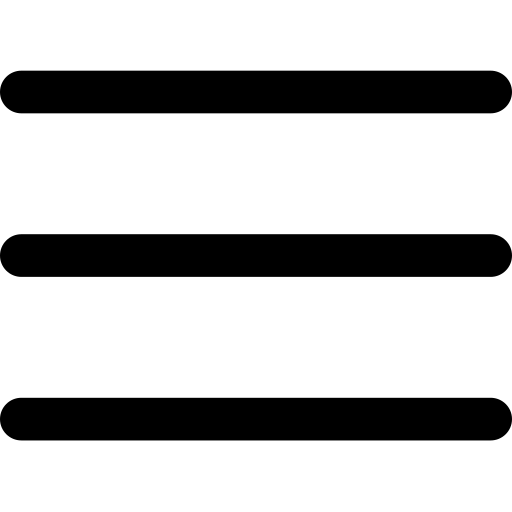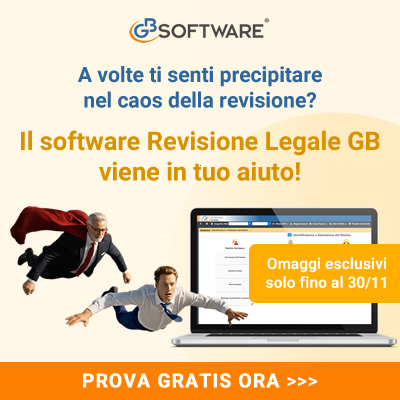Dopo una lunga gestazione l’Organismo Italiano di Contabilità ha emesso in via definitiva il nuovo OIC 30 che tratta delle regole che vanno seguite nella redazione di un bilancio intermedio. Il contributo si preoccuperà di sintetizzare gli aspetti rilevanti del nuovo OIC e di evidenziare le novità rispetto alla precedente versione.
Premessa
Il nuovo OIC 30 è stato rilasciato in versione definitiva nel giugno di quest’anno.
Va segnalato che è passato un tempo più lungo del normale tra la fine della pubblica consultazione (novembre 2024) e la pubblicazione definitiva e che la sua applicazione obbligatoria è stata posticipata al 2026.
La precedente versione dell’OIC 30 era datata 2006 non avendo subito da allora cambiamenti neanche quando, prima nel 2014 e poi nel 2016, l’OIC aveva modificato pressoché tutti i principi contabili a seguito delle riforme delle normative dei bilanci d’esercizio e consolidati rese obbligatorie dal rilascio di nuove direttive europee.
Risulta pertanto evidente come una parte rilevante del principio sia dedicata a fornire chiarimenti tecnici e aggiornamenti delle prescrizioni contenute nel vecchio OIC e, come sempre è avvenuto nella riscrittura dei principi contabili italiani a partire dal 2014, a rendere le prescrizioni dell’OIC 30 le più simili possibili a quelle del principio internazionale (IAS 34) che invece ha subito, dalla sua introduzione (1998), numerose modifiche di cui l’ultima risalente all’aprile 2024 (a seguito della pubblicazione del nuovo IFRS 18 “Presentazione e informativa nel bilancio“, che sostituirà lo IAS 1 “Presentazione del bilancio” a partire dagli esercizi che cominciano dal primo gennaio 2027).
Come è ovvio, l’OIC 30 disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa del bilancio intermedio.
L’OIC nella rivisitazione dell’OIC 30 si è posto due principali obiettivi:
- fornire un principio di riferimento chiaro ed esaustivo che potesse essere applicato dalle imprese di qualsiasi dimensione e,
- favorire da un lato la comparabilità delle informazioni e, dall’altro, la trasparenza nei confronti del mercato e dei terzi.
Le finalità dell’OIC 30 e la sua nuova struttura
Dal raffronto tra la vecchia e nuova versione del principio emerge evidente il radicale cambiamento di esposizione e struttura del principio.
La versione del 2006 era caratterizzata, come pressoché tutti i principi contabili italiani ante modifiche del 2014, da tre elementi fondamentali:
- richiamo delle casistiche in cui la legge richiedeva la predisposizione di un bilancio intermedio,
- definizione dei principi applicabili alle società a capitale chiuso,
- definizione delle regole riferite alle società quotate nei mercati regolamentati con particolare enfasi alle differenze tra le relazioni trimestrali e quelle semestrali.
La versione attuale (impostata con paragrafi numerati come avviene nei principi contabili internazionali) ha eliminato sia la parte riferita alla disamina delle casistiche in cui la legge italiana richiede la predisposizione di un bilancio intermedio che quella dedicata alle differenti casistiche tra società quotate e non, per indicare delle regole applicabili a qualsiasi impresa che, in maniera obbligatoria o facoltativa, redige e pubblica un bilancio intermedio.
I bilanci intermedi sono definiti come i bilanci relativi a periodi contabili di durata inferiore all’intero esercizio che hanno l’obiettivo di informare i terzi circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio e, quando obbligatori per legge (come nel caso delle società quotate su un mercato regolamentato ma non obbligate all’uso degli IFRS – es: quotate su Euronext Growth Milan -), rispondono anche all’esigenza degli utilizzatori del bilancio di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale.
Tuttavia, risulta chiaro, come già prescritto anche nella precedente versione, che l’OIC 30 debba essere utilizzato anche dalle società che scelgono volontariamente di pubblicare un bilancio intermedio sia esso d’esercizio o consolidato non essendo previste differenze tra il bilancio individuale e quello consolidato.
Va, tuttavia, segnalato un punto critico della nuova versione che potrebbe generare ambiguità nella redazione di bilanci intermedi richiesti dalla legge in situazioni particolari (es: perdita del capitale, operazioni straordinarie etc.) e rendere vano il dichiarato intento di favorire la chiarezza e la comparabilità dei dati della situazione periodica con il bilancio annuale.
Ci si riferisce al fatto che nella precedente versione appariva cogente l’obbligo di utilizzare i principi enunciati dall’OIC 30 nella redazione di bilanci intermedi in qualsiasi situazione essa fosse, ordinaria (es: bilancio semestrale), straordinaria (es: fusione) o addirittura patologica (es: perdita del capitale).
A titolo esemplificativo, per la perdita del capitale, la versione del 2006 enunciava in maniera esplicita che nella redazione della situazione patrimoniale (costituita non solo dallo stato patrimoniale ma anche dal conto economico) si dovessero seguire le stesse regole e gli stessi principi utilizzati per il bilancio d’esercizio e che si dovesse corredare tale situazione patrimoniale da una nota integrativa seppur semplificata.
Nella attuale versione si legge, testualmente, nella sezione “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”, al paragrafo 5: “Il principio contabile disciplina la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni fisiologiche nella vita della società. Pertanto, non disciplina il contenuto di quelle situazioni contabili redatte in momenti particolari della vita della società, quali ad esempio la situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447 del codice civile. Ciò non esclude che, nell’ambito della loro discrezionalità, gli amministratori possano applicare i criteri di valutazione previsti dall’OIC 30 nella redazione della situazione patrimoniale.”
Tale passaggio può ingenerare, nel lettore frettoloso e non edotto della struttura degli attuali OIC, la convinzione che l’OIC 30 attribuisca una assoluta libertà al redattore della situazione patrimoniale intermedia in situazioni straordinarie e/o patologiche, sulla base di una sua decisione discrezionale, si spera, sempre tecnica.
A giudizio dello scrivente tale conclusione non è accettabile né in linea con i dettami e le finalità dell’OIC 30 e, più in generale, con la filosofia della comparabilità dei dati che permea la redazione di bilanci siano essi annuali o intermedi.
Le motivazioni che inducono lo scrivente a tale conclusione risiedono innanzitutto nella differente autorevolezza delle varie sezioni del principio.
È noto che la sezione “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” non sono parte integrante del principio e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fine di fissare regole di comportamento per il redattore del bilancio.
Va, quindi, constatato che nel corpo del principio, nella sezione denominata “Rilevazione e valutazione” al paragrafo 13 si legge testualmente: “I bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi principi contabili applicati nel bilancio di esercizio…” e lo stesso viene indicato per i criteri di redazione e valutazione da applicare (paragrafi 14 e 15) annullando la discrezionalità dei redattori nel poter applicare principi e/o criteri differenti da quelli usati nel bilancio d’esercizio senza inficiare la comparabilità dei dati elaborati, come pure debba essere preso atto che la giurisprudenza consolidata ha oramai codificato, rimanendo al citato esempio della perdita del capitale, che la situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447 debba essere redatta con gli stessi principi del bilancio d’esercizio e debba essere corredata da una nota integrativa.
Quindi, sempre a giudizio dello scrivente, non appare possibile in situazioni straordinarie e/o patologiche attribuire una discrezionalità di scelta al redattore del bilancio intermedio che dovrà necessariamente essere redatto secondo gli stessi principi e criteri di valutazione del bilancio annuale.
Si ricorda da ultimo che per alcune situazioni particolari della vita societaria quali la liquidazione (OIC 4) o la fusione e scissione (OIC5) esistono dei principi ad hoc che tuttavia non coprono tutte le casistiche in cui una società è chiamata per legge a redigere un bilancio infrannuale.
L’OIC 30 indica che il bilancio intermedio deve avere anche il rendiconto finanziario (non presente nella precedente versione in quanto allora non obbligatorio per legge) assieme allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa, seguendo gli stessi obblighi previsti per il bilancio annuale (quindi rendiconto finanziario solo se si redige il bilancio annuale in forma ordinaria).
Gli schemi di bilancio sono gli stessi utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio, garantendo così la piena confrontabilità tra i dati intermedi e quelli annuali.
Inoltre, in una logica di chiarezza espositiva, l’attuale OIC 30 richiede che il redattore indichi che ha rispettato tutte le disposizioni del principio nella nota integrativa del bilancio intermedio.
I principi e i criteri da adottare per la redazione dei bilanci intermedi
Come già detto in precedenza l’OIC 30 obbliga il redattore ad applicare le stesse regole di redazione del bilancio d’esercizio o del bilancio consolidato, considerando il periodo contabile intermedio (normalmente di 3, 6, o 9 mesi) come un autonomo “esercizio”.
Ne discende che i costi e ricavi debbano essere contabilizzati in coerenza con i postulati di bilancio dell’OIC 11 (competenza, prudenza etc.). Ad esempio, i ricavi percepiti stagionalmente o ciclicamente non devono essere anticipati o differiti se ciò non sarebbe ammesso nel bilancio annuale e lo stesso vale per le componenti di costo.
Le valutazioni devono riflettere la situazione esistente alla data di chiusura del periodo intermedio (senza possibilità di anticipare o differire ricavi e costi che non sarebbero trattati in tal modo nel bilancio annuale) e le variazioni di stima e di valutazione sono consentite solo quando, a seguito dell’ottenimento nel periodo di ulteriori informazioni, sia necessario aggiornare tali stime e valutazioni.
Rilevante è il fatto che le decisioni prese in un bilancio intermedio condizionano i dati numerici dei successivi bilanci intermedi o annuali.
Ne discende che, se si decide di non capitalizzare un costo nel bilancio intermedio in quanto non sussistono condizioni per la sua capitalizzazione, tale costo non potrà più essere capitalizzato nei successivi bilanci intermedi o in quello annuale.
L’unica eccezione è rappresentata dagli eventuali cambiamenti di principi contabili che, se intervenuti dopo la chiusura dell’ultimo esercizio, saranno recepiti solo nel bilancio d’esercizio successivo, secondo quanto previsto dall’OIC 29.
Si riporta in forma tabellare le indicazioni dell’OIC 30 su alcuni aspetti rilevanti del bilancio.
| Fattispecie | Indicazioni OIC 30 |
| Ammortamento immobilizzazioni | L’ammortamento deve essere effettuato in relazione ai soli cespiti che sono disponibili e pronti all’uso nel periodo, applicando l’aliquota annua proporzionata alla durata del periodo infrannuale. È consentito applicare la mezza aliquota per le acquisizioni effettuate nel periodo. Non è consentito tenere in considerazione acquisizioni o cessazione pianificate per una data successiva al termine del periodo. |
| Costi di manutenzione ordinaria | Ogni costo deve essere rappresentato nei bilanci intermedi in base al suo effettivo sostenimento. |
| Costi di sviluppo | Se non sono soddisfatte tutte le condizioni per la capitalizzazione previste dall’OIC 24 alla data del bilancio intermedio, non si procede alla capitalizzazione. |
| Fondi rischi e oneri | Sono rilevati nel bilancio intermedio se sono soddisfatti, alla chiusura del periodo, i requisiti previsti dall’OIC 31. Le analisi delle passività e delle eventuali stime di nuovi accantonamenti e/o gli aggiornamenti di quelli già esistenti vengono fatti sulla base delle informazioni esistenti a tale data. |
| Incentivi e premi di risultato | Nei bilanci intermedi si potrà includere tali elementi se entro la chiusura del periodo sono ragionevolmente certi. Si dovrà fare riferimento a tutte le informazioni disponibili (esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali) per stimare nel miglior modo possibile la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine anno. |
| Rimanenze magazzino | Le rimanenze devono essere valutate con gli stessi criteri utilizzati per il bilancio annuale. Si dovrà pertanto applicare la stessa configurazione di costo e stimare la eventuale necessità di svalutazioni per ricondurre le scorte al valore di realizzo, sulla base delle informazioni note alla data della valutazione, senza anticipare eventuali fenomeni di recupero dei periodi successivi. |
| Sconti quantità determinati a fine anno | Nel bilancio intermedio la stima viene effettuata sulla base dell’esperienza storica e/o elaborazioni statistiche al fine di determinare se i volumi di vendita previsti a fine anno sono tali da far applicare lo sconto pattuito da contratto. Se non si prevede di raggiungere tali volumi i ricavi saranno rilevati senza tenere conto dello sconto, viceversa, se si prevede di realizzare le condizioni del contratto i ricavi saranno rilevati al netto dello sconto. |
| Svalutazioni immobilizzazioni | Nel bilancio intermedio si procede dapprima con la verifica dell’esistenza di eventuali indicatori di potenziali perdite (trigger events) e solo in presenza di tali situazioni si procede con la verifica del valore recuperabile (maggiore tra valore d’uso e fair value) da confrontare con il valore netto contabile |
Principali novità
Possono essere sintetizzate in tre aspetti principali:
- calcolo delle imposte (si tratta del cambiamento più rilevante);
- svalutazione delle imposte anticipate (specificazione opportuna ma già seguita nella prassi applicativa precedente);
- svalutazioni e ripristini di valore (anche in questo caso già utilizzata nella migliore prassi applicativa precedente).
Calcolo imposte e svalutazione imposte anticipate
Il nuovo OIC 30 si allinea alla metodologia di calcolo dello IAS 34 che prevede il calcolo delle imposte sulla base dell’aliquota fiscale annua effettiva stimata.
Si tratta di un cambio radicale rispetto alla versione precedente che vietava espressamente tale calcolo privilegiando invece un calcolo basato sull’aliquota fiscale annua in vigore nell’esercizio da applicare ai risultati lordi dei singoli periodi.
Si presenta numericamente tale radicale cambio di visione tra il vecchio e nuovo OIC 30, con un esempio volutamente molto semplificato (si è mantenuto in entrambi i casi la stessa aliquota fiscale annua pari al 40% anche se si tratta di due aliquote calcolate in modo diverso come descritto in precedenza) ma che da contezza dei significativi effetti sul risultato che i due metodi hanno.
| Vecchio OIC | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | Totale |
| Risultato lordo | 10.000 | -5.000 | -3.000 | -2.000 | 0 |
| Imposte (40%) | -4.000 | 2.000 | 1.200 | 800 | 0 |
| Nuovo OIC | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | Totale |
| Risultato lordo | 10.000 | -5.000 | -3.000 | -2.000 | 0 |
| Imposte (40%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L’unica eccezione al nuovo metodo sopra esposto riguarda l’eventuale svalutazione delle imposte anticipate rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale che, per motivi di prudenza, deve essere contabilizzata per intero nel periodo intermedio in cui venisse meno il requisito della ragionevole certezza.
Svalutazioni e ripristini di valore delle immobilizzazioni
Viene enfatizzato come nei casi in cui i principi contabili non ammettono il ripristino di valore di un’attività precedentemente svalutata (casi classici quelli dell’avviamento e degli oneri pluriennali), le svalutazioni effettuate nel bilancio intermedio non possono essere ripristinate nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.
di Andrea Soprani