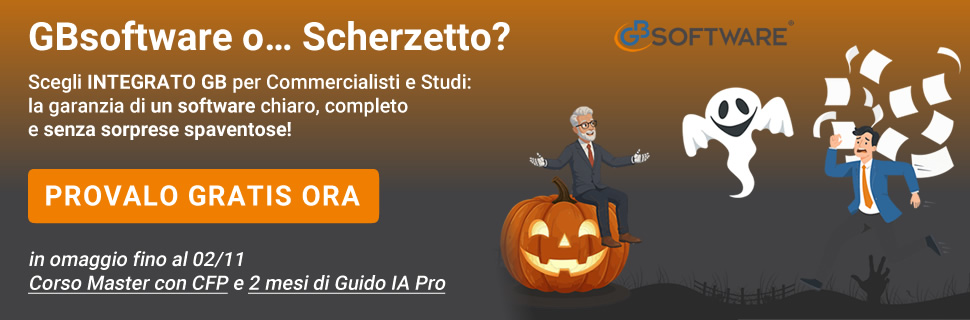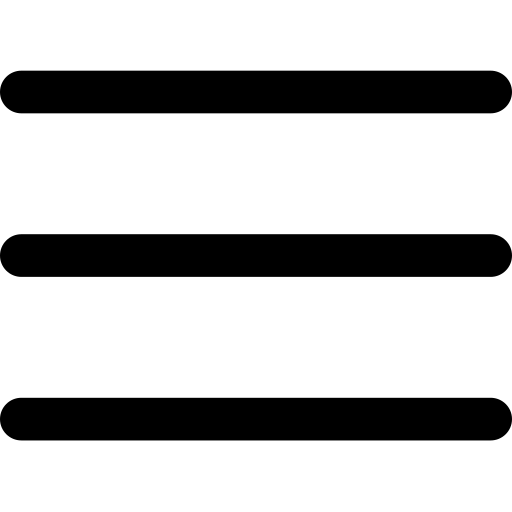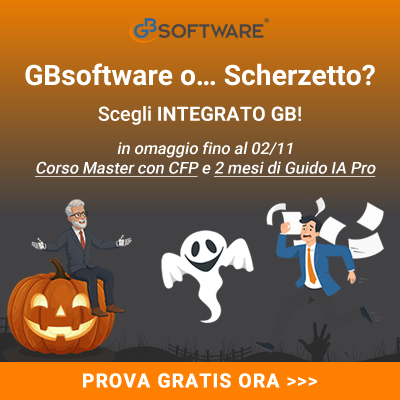La sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha generato un acceso dibattito interpretativo tra la tesi della proroga “a cascata” e quella “limitata”. Il contrasto giurisprudenziale, alimentato dalle diverse letture delle Corti di merito, è stato definitivamente risolto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 960/2025, e successivamente consacrato dalle Sezioni Unite, che ha riconosciuto l’efficacia generalizzata della sospensione di 85 giorni.
Il contesto normativo emergenziale
L’articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha rappresentato il fulcro della risposta legislativa all’emergenza pandemica per quanto concerne i termini tributari. Il comma 1 di tale articolo ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
L’elemento normativo cruciale è contenuto nel comma 4, il quale, per i termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio all’articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015. Tale rinvio è fondamentale per comprendere la logica del legislatore: l’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 stabilisce un principio di “simmetria”. Esso prevede che, in caso di eventi eccezionali che comportino la sospensione dei versamenti per i contribuenti, anche i termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori siano sospesi per un periodo corrispondente. La ratio è quella di bilanciare gli interessi, restituendo all’Amministrazione finanziaria il tempo operativo di cui è stata privata a causa delle restrizioni emergenziali.
L’elemento rilevante è rappresentato dalla esclusione dal richiamo del comma 2 dell’articolo 12 – che avrebbe comportato una proroga biennale -, richiamato solo nel D. L. n. 18/2020, ma non anche nel testo definitivo del decreto convertito in legge che ha ristretto il rinvio ai soli commi 1 e 3 (quest’ultimo irrilevante per la fase di accertamento, in quanto riguardante la sola notifica delle cartelle di pagamento).
La decisione di limitare il rinvio normativo ha sortito un effetto ben preciso: lo slittamento dei termini è stato circoscritto alla durata effettiva della sospensione emergenziale, ossia gli ottantacinque giorni, evitando così proroghe più ampie.
Un aspetto di rilievo è la deroga esplicita all’articolo 3, comma 3, della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), che sancisce il divieto di proroga dei termini di accertamento. Occorre tuttavia precisare che lo Statuto, pur rappresentando un corpus normativo di particolare rilevanza sistematica, mantiene il rango di legge ordinaria. Sicché una deroga esplicita è da ritenersi pienamente legittima sul piano della gerarchia delle fonti, in applicazione del principio della lex posterior derogat priori.
L’introduzione di tale deroga è stata dettata dall’esigenza concreta di restituire all’Amministrazione finanziaria il lasso temporale di cui questa è stata oggettivamente privata durante il periodo di c.d. lockdown con tutte le conseguenti restrizioni operative.
Il contrasto interpretativo
L’applicazione dell’articolo 67 ha generato un acceso dibattito giurisprudenziale, polarizzato su due tesi contrapposte.
La prima tesi detta della “proroga a cascata”, proposta dall’Amministrazione finanziaria, ha interpretato la sospensione come una proroga generalizzata (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2020). Questa interpretazione postulava che la sospensione di 85 giorni non si limitasse a posticipare le scadenze del 2020, ma producesse uno slittamento generalizzato per tutte le annualità il cui termine di decadenza era ancora pendente durante il periodo emergenziale.
A seguire questa logica, l’anno fiscale non sarebbe più terminato al 31 dicembre, ma a marzo dell’anno successivo, con conseguenze in tema di certezza per i contribuenti e mettendo a rischio la validità di moltissimi atti notificati nei primi mesi degli anni successivi al 2020.
La seconda tesi, della c.d. “proroga limitata”, ha proposto un differente orientamento nato in seno alle Corti di Giustizia Tributaria di merito (cfr., fra le tante, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, sentenza n. 474/2024; Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sentenza n. 6126/2024; Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 2329/2024; Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sentenza n. 6181/2024). Secondo tale approccio interpretativo, una proroga generalizzata sarebbe stata irragionevole e sproporzionata se estesa oltre il 2020, anno in cui i contribuenti avevano beneficiato della sospensione dei versamenti. Venuto meno tale beneficio per le annualità successive, non vi sarebbe stata ragione di concedere un vantaggio temporale al Fisco.
Le pronunce difformi delle Corti di merito avevano generato un quadro di riferimento disomogeneo con ricadute significative in tema di avvisi di accertamento notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 marzo 2023 e 2024 riferiti alle annualità di imposta 2016 e 2017.
Una simile incertezza interpretativa non si limitava soltanto a compromettere il principio cardine dell’ordinamento tributario di certezza del diritto, ma esponeva gli Enti impositori al rischio di vedersi invalidare un numero considerevole di atti impositivi già notificati, con evidenti ripercussioni sul gettito fiscale. L’assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato non consentiva agli uffici di operare con la dovuta sicurezza, alimentando la possibile creazione di un notevole contenzioso.
L’intervento nomofilattico della Corte di Cassazione
Per dirimere il contrasto interpretativo, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce e Gorizia hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis, comma 1 codice di procedura civile. L’intervento nomofilattico della Suprema Corte veniva così sollecitato allo scopo di superare definitivamente l’impasse interpretativo e così assicurare una più uniforme applicazione della disciplina qui in esame.
La svolta è arrivata con ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata, per la prima volta, a favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”, seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria. La decisione fornisce comunque una indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale. La controversia riguardava un’istanza di ammissione al passivo fallimentare presentata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’ammissione al passivo era stata rigettata a motivo dell’estinzione del credito per intervenuta prescrizione. L’Agente della riscossione ha impugnato tale decisione, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto applicare la disciplina emergenziale dettata dall’articolo 67 del D. L. n. 18/2020, letto in combinato disposto con l’articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agente della riscossione affermando che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all’interno dell’arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell’articolo 67, sia nel richiamo espresso all’articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali. Ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all’interno del periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L’autorevolezza di tale principio è stata definitivamente consacrata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite. Con tale provvedimento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025, la cui portata è stata così estesa in via definitiva anche all’ambito tributario.
Successive pronunce della Corte (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento, estendendolo a casi specifici di accertamento fiscale e confermando la legittimità degli atti notificati entro il termine prorogato di 85 giorni.
Ciò significa che ogni periodo di imposta per il quale l’attività di accertamento era ancora esercitabile nel marzo 2020 beneficia di questo differimento. La Cassazione ha quindi avallato la lettura proposta dall’Amministrazione finanziaria secondo la quale il termine per l’accertamento, se ancora pendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automatica di ottantacinque giorni per effetto della legge. In pratica, ogni volta che il Fisco avrebbe potuto teoricamente notificare un atto di accertamento perché non era ancora scaduto il relativo termine, quel termine ha smesso di decorrere dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tale interruzione va poi sommata alla scadenza ordinaria del 31 dicembre prevista per gli accertamenti, con la conseguenza che lo slittamento si è riverberato, come un effetto “a cascata”, anche sulle annualità successive al 2020. Il nuovo termine effettivo per la notifica degli avvisi di accertamento cade pertanto al 26 marzo 2026.
Anche le attività di riscossione rientrano nell’ambito applicativo della pronuncia della Cassazione con estensione del termine effettivo al 26 marzo 2026. Ciò significa che anche i termini relativi alla notifica delle cartelle di pagamento e alle altre procedure esecutive hanno subito la medesima sospensione di 85 giorni, con il conseguente slittamento delle scadenze previste per l’Agente della Riscossione.
Conclusioni
Il fondamento logico-giuridico della soluzione adottata risiede nella ratio compensativa della normativa emergenziale, ossia restituire all’Amministrazione finanziaria il tempo operativo limitato dall’emergenza COVID, così da garantire l’effettività dell’azione accertatrice senza vulnerare i diritti del contribuente oltre il ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.
Permangono, tuttavia, alcune perplessità dottrinali sulla perpetuazione di un regime eccezionale ormai distante dalla contingenza che lo aveva reso necessario. Proprio per tale motivo, si deve guardare con favore la promulgazione dell’art. 22 del Decreto Legislativo n. 81/2025 che così recita: “A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle entrate.”
Tale disposizione, pur non risolvendo le controversie relative agli atti già notificati o da notificare prima di tale data, pone fine all’applicazione dell’effetto “a cascata” per il futuro, cercando di ripristinare la certezza dei rapporti tra Fisco e contribuente.
di Edoardo Ferragina
TAG accertamentocovidriscossione