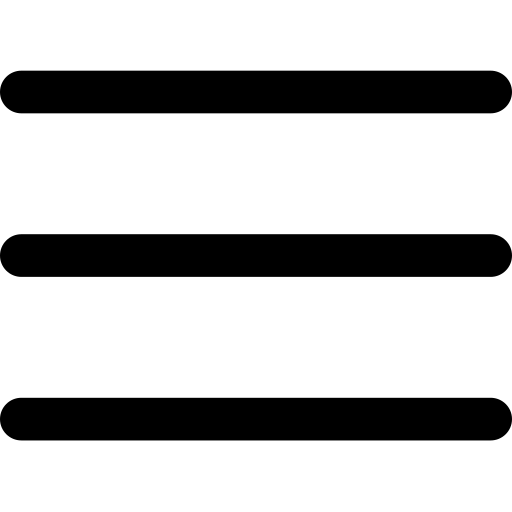di Rosanna Acierno
Sono sempre più frequenti le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sull’utilizzo in dichiarazione, da parte di imprese, di fatture per operazioni ritenute inesistenti che spesso, ancorché siano realmente avvenute, inducono i verificatori (prima) e l’Agenzia delle Entrate (dopo) a contestare in capo al committente acquirente l’indebita detrazione dell’Iva. A fronte di simili rettifiche diventa particolarmente complicato difendersi anche perché, molte volte, avendo effettivamente ricevuto i beni o i servizi e regolarmente pagati, l’acquirente mal comprende la contestazione del Fisco che, invece, ritenendo le operazioni soggettivamente fittizie in quanto rese da soggetti di fatto non operativi, pretende l’Iva corrisposta e detratta.

Premessa
Sebbene, spesso, si parli genericamente di false fatturazioni, occorre innanzitutto operare un importante distinguo tra fatture oggettivamente inesistenti e fatture soggettivamente inesistenti.
In particolare, per utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti si intende l’utilizzo di fatture di acquisto riferite a operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà: si tratta di fatture di acquisto che attestano una cessione di beni o una prestazione di servizi mai avvenuta. In tal caso, sotto il profilo tributario, il costo è indeducibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap e l’Iva è indetraibile poiché si tratta di transazioni fittizie per le quali, secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito, manca il requisito della certezza.
Per utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti si intende, invece, quello riferito a fatture per a operazioni realmente avvenute, ma tra soggetti differenti rispetto a chi è indicato nel documento. Tale contestazione è mossa dall’Amministrazione finanziaria nelle ipotesi in cui il cedente o il prestatore non abbia una struttura idonea per eseguire l’operazione o ancora quando risulti introvabile a seguito della cessazione dell’attività e non abbia adempiuto ai principali obblighi fiscali (i.e. dichiarazione, versamento, ecc.).
In tali casi, sotto il profilo tributario, l’Iva corrisposta e detratta dall’acquirente è indetraibile, mentre il relativo costo è comunque deducibile sempreché realmente sostenuto e inerente all’attività svolta.
Attenzione
| Sul versante penale, l’articolo 2 del D. Lgs. 74/00 rubricato “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indichi in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (indifferentemente se sotto il profilo soggettivo o oggettivo). |
La contestazione di fatture soggettivamente inesistenti
Come innanzi accennato, la fattispecie di fatture soggettivamente inesistenti si realizza quando, a fronte di operazioni realmente avvenute, quali cessioni di beni o prestazioni di servizi, le stesse sono fatturate da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente ceduto i beni o erogati i servizi.
Il tipico caso – che nella pratica può declinarsi nei più svariati modi – riguarda il destinatario finale che riceve la fattura per l’acquisto della merce o per la prestazione di servizio da un soggetto che non è l’effettivo proprietario della merce o l’effettivo prestatore del servizio, bensì una società cosiddetta “cartiera” che, essendo priva di adeguata struttura operativa, si interpone tra il fornitore e l’acquirente emettendo soltanto le fatture di vendita.
In tal caso, l’Amministrazione finanziaria contesta la detraibilità dell’Iva assolta dal cessionario/committente.
L’assolvimento dell’onere probatorio
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria e di quella nazionale, in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, ai fini del recupero dell’IVA è l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare non solo che la merce o il servizio è stato, di fatto, reso da un soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura, ma anche che l’acquirente/cessionario era a conoscenza di ciò.
Solo una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia assolto nei modi indicati il proprio onere probatorio, l’acquirente/cessionario è tenuto a dimostrare che non poteva conoscere l’intento fraudolento dei propri fornitori, avendo attuato una condotta diligente.
Pertanto, in mancanza di elementi probatori certi e inconfutabili addotti dall’Amministrazione finanziaria che dimostrino che il servizio, in realtà, è stato reso da un soggetto diverso da quello che ha emesso la fattura e che attestino la consapevolezza dell’acquirente/cessionario di partecipare alla frode fiscale, non è possibile disconoscere in capo a quest’ultimo il diritto di detrazione dell’Iva corrisposta a fronte delle cessioni fatturate.
Ferma restando, infatti, la tutela dell’acquirente/cessionario in buona fede, che esclude alla radice la possibilità di disconoscere la detrazione, la giurisprudenza nazionale e, in particolar modo, comunitaria (ex multis, Corte di Giustizia Ue 4 giugno 2020 n. C-430/19) esige che sia l’Erario a dover assolvere l’onere di provare la consapevolezza dell’acquirente/cessionario circa la partecipazione alla frode oppure che lo stesso “non poteva non sapere” della frode stessa.
Le possibili strategie difensive del cessionario/committente incolpevole
Al fine di poter mantenere il proprio diritto alla detrazione dell’Iva, il cessionario/committente a cui viene contestato l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti è chiamato a dimostrare, generalmente in sede contenziosa attraverso l’impugnazione tempestiva dell’atto impositivo:
- da un lato, la violazione dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- e dall’altro, la propria diligenza e buona fede nella scelta dei fornitori e la propria inconsapevolezza del presunto illecito perpetrato a monte della filiera.
In particolare, in sede di ricorso introduttivo, laddove dovesse emergere che l’Ente accertatore non abbia provato, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l’inesistenza soggettiva delle fatture, è opportuno eccepire l’illegittimità dell’atto impositivo per violazione del principio dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione Finanziaria, da ultimo peraltro rafforzato dal Legislatore attraverso l’articolo 7, comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/92.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione e la giurisprudenza comunitaria, in ipotesi di fatturazione soggettivamente inesistente, è l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare l’interposizione fittizia ad opera dell’apparente cedente/prestatore ovvero la sua natura di “cartiera”, con inesistenza di una struttura operativa, e la susseguente “connivenza” con la frode, anche mediante presunzioni, a condizione che esse siano gravi, precise e concordanti (ex multis, Corte Cassazione, sentenza n. 428/2015).
Sulla base dei principi appena enunciati, l’Amministrazione finanziaria è dunque chiamata all’osservanza del dovere di espletare un’istruttoria procedimentale approfondita al fine di stabilire la regolarità o l’irregolarità di una operazione IVA, nonché il grado di consapevole partecipazione dei diversi soggetti coinvolti, evitando di limitarsi a contestare apoditticamente la regolarità dell’operazione al fine di negare l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA (cfr. in tal senso, Corte di Giustizia UE 21.6.2012 cause riunite C-80/11 e C-142/11, Corte di Giustizia UE 6.12.2012 causa C-285/11, Corte di Giustizia UE 13.2.2014 causa C-18/13, Corte di Giustizia UE 22.10.2015 causa C-277/14, successivamente confermato anche da Corte di Giustizia UE 18.5.2017 causa C-624/15 e da Corte di Giustizia Ue 4 giugno 2020 n. C-430-19 e Corte di Cassazione, sentenze n. 20059/2014, n. 15044/2014, n. 24490/2015 e n. 967/2016, n. 15640/2023, n. 33620/2023 e n. 20587/2019).
Attenzione
| Per ritenere coinvolto il cessionario/committente, è necessaria la presenza di “elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente”. |
Ne consegue che, nella specifica ipotesi di contestazione legata alla presunta inesistenza soggettiva delle operazioni poste in essere da un fornitore, l’Ufficio non può desumere in via automatica ed acritica l’indebita detrazione dell’Iva corrisposta dall’acquirente/cessionario sugli acquisti per il solo fatto di avere intrattenuto rapporti commerciali con presunte “cartiere”, ma è tenuto a fornire un’adeguata motivazione e ad operare una specifica analisi in relazione agli specifici elementi che lo hanno indotto a ritenere inesistenti le operazioni commerciali contestate, dimostrando in modo puntuale e non contraddittorio che il contribuente sapeva della frode, a tal fine producendo email, testimonianze di terzi, documenti attestanti la retrocessione del denaro oppure il pagamento a soggetti diversi dal reale fornitore.
Inoltre, è comunque opportuno eccepire l’illegittimità dell’atto impositivo anche per la comprovata buona fede del cessionario e per assenza assoluta di consapevolezza nel coinvolgimento nella presunta frode dimostrabile mediante idonea documentazione attestante:
- l’effettuazione dell’operazione contestata;
- l’effettuazione dell’avvenuto pagamento;
- l’applicazione di analoghe condizioni contrattuali commerciali ed economiche da parte del presunto fornitore responsabile della frode rispetto a quelle applicate da altri fornitori (ex multis, Corte Cassazione n. 18009/2012).
Sul punto, si richiamano, peraltro, le conclusioni dell’Avvocato Generale nelle cause 5.7.2017 C-374/16 e C-375/16, secondo cui il contribuente deve poter legittimamente fare affidamento sugli elementi formali della transazione, quali essi appaiono dai documenti contabili.
Attenzione
| Certamente questo non significa che il contribuente possa operare in modo leggero o incauto, in quanto è sempre obbligato a tenere un comportamento avveduto. Se, dunque, egli è tenuto a svolgere alcuni controlli, è tuttavia certo che tali controlli non possano essere tali e tanti da divenire irragionevoli o economicamente gravosi. È infatti impensabile che il cessionario sia tenuto a verificare la coincidenza dell’indirizzo indicato dal fornitore con la sede dell’attività del cedente o se quest’ultimo abbia mezzi e locali idonei all’attività svolta, se le condizioni della vendita fanno presumere, coerentemente, che vi sia stata una operazione triangolare. |
Molto importante si profila, inoltre, l’enunciato, ormai costante, secondo cui l’Amministrazione finanziaria non può pretendere di trasferire sui soggetti passivi i propri compiti di controllo, non dovendo e, soprattutto, non potendo il contribuente ergersi a “poliziotto del Fisco” (ex multis, cfr. Corte di Giustizia UE 21.6.2012 cause riunite C-80/11 e C-142/11).
L’operatore economico deve poter fare, infatti, affidamento sulla liceità dell’operazione che intraprende, senza rischiare di essere privato del proprio diritto alla detrazione dell’Iva.
TAG Fatturefatture inesistenti