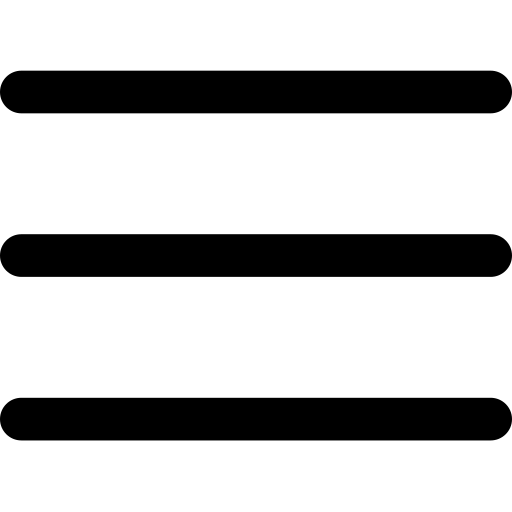La scadenza del 1° dicembre 2025 per la seconda o unica rata degli acconti rappresenta un passaggio cruciale nella pianificazione fiscale di imprese e professionisti. Si analizzano criteri di calcolo, soglie di esonero e la scelta tra metodo storico e previsionale alla luce delle numerose novità normative. Vengono esaminati gli impatti della maxi deduzione, dell’IRES premiale e del Concordato Preventivo Biennale, insieme ai vincoli alle compensazioni. È stata dedicata particolare attenzione agli aspetti sanzionatori e operativi, evidenziando il ruolo strategico del commercialista nella gestione dell’adempimento.
Il perimetro dell’adempimento: soggetti interessati, soglie di esonero e struttura del sistema
La scadenza del 1° dicembre 2025 rappresenta il principale snodo autunnale nella gestione degli adempimenti fiscali di imprese e professionisti, interessando la seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e delle principali imposte sostitutive. La coincidenza con la fase finale dell’esercizio rende questo appuntamento particolarmente delicato, perché la proiezione del risultato economico dell’anno in corso e la verifica delle novità normative intervenute tra 2024 e 2025 devono essere integrate in un’analisi coerente e tempestiva.
L’acconto è dovuto solo se l’imposta netta dell’anno precedente supera determinate soglie: 51,65 euro per i contribuenti IRPEF e 20,66 euro per gli IRES, con limiti analoghi per l’IRAP. Sono esclusi i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2025, coloro che presumibilmente chiuderanno l’anno a credito e gli eredi del contribuente deceduto nel periodo oggetto di versamento. Si tratta di verifiche preliminari semplici, ma essenziali per evitare versamenti non dovuti.
Il sistema di calcolo continua a fondarsi sul binomio metodo storico e metodo previsionale. Il primo, di taglio prudenziale, ancora l’acconto all’imposta determinata nel modello Redditi 2025 (anno 2024). I contribuenti non ISA versano il 40% a giugno e il 60% a novembre; ISA, forfettari, minimi e soggetti collegati ai contribuenti ISA versano invece due rate paritarie al 50%. Se l’acconto complessivo non supera 257,52 euro, il versamento avviene in un’unica soluzione entro la scadenza di dicembre.
Il metodo previsionale consente invece di parametrare l’acconto all’imposta stimata per il 2025. È utilizzabile quando vi siano elementi concreti a supporto di una minore imposizione: riduzione dei ricavi, incremento degli oneri deducibili, accesso a nuove agevolazioni, effetti della maxi deduzione, dell’IRES premiale o dell’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB).
Il vantaggio della flessibilità è controbilanciato dal rischio sanzionatorio, giacché un acconto insufficiente genera gli effetti dell’omesso versamento con sanzione ordinaria del 25%, riducibile tramite ravvedimento.
Attenzione: La scadenza del 1° dicembre 2025 rappresenta uno snodo cruciale della pianificazione fiscale: l’acconto va ricalcolato tenendo insieme la proiezione del risultato dell’esercizio e l’impatto delle novità normative, scegliendo consapevolmente tra metodo storico e metodo previsionale per evitare versamenti indebiti o insufficienze sanzionabili.
Operatività del versamento: compensazioni, blocchi, maxi deduzione e IRES premiale
Sul piano operativo, la gestione degli acconti passa ormai in modo quasi integrale attraverso il modello F24 telematico, che rappresenta lo strumento ordinario per tutti i versamenti tributari, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA. Dal 1° luglio 2024 si è ulteriormente accentuata la centralità dei canali Entratel e Fisconline: qualunque F24 che esponga crediti in compensazione, anche qualora il saldo complessivo sia a debito, deve obbligatoriamente essere trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’home banking resta utilizzabile esclusivamente per gli F24 privi di compensazioni, circostanza che richiede una verifica preliminare della struttura del modello prima dell’invio.
La disciplina delle compensazioni orizzontali si è progressivamente resa più rigida, con l’obiettivo dichiarato di limitare gli utilizzi indebiti dei crediti d’imposta. Rimane in vigore il tetto generale di 2 milioni di euro annui per le compensazioni, cui si affianca il limite autonomo di 250.000 euro per i crediti di natura agevolativa. A questi limiti quantitativi si sommano numerose restrizioni qualitative: la compensazione è vietata in presenza di carichi affidati alla riscossione superiori a 100.000 euro relativi a imposte erariali o ad altri atti dell’Agenzia delle Entrate per i quali siano decorsi i termini di pagamento senza sospensione o rateazione. Ulteriore blocco deriva dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, che inibisce la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo erariali superiori a 1.500 euro, fino alla loro regolarizzazione. Rimangono, invece, sempre compensabili — nel rispetto delle norme proprie — i crediti previdenziali e assistenziali INPS e INAIL, non soggetti al meccanismo dei blocchi previsti per i tributi erariali.
Queste restrizioni rendono indispensabile una verifica sistematica della posizione debitoria del contribuente prima di programmare l’utilizzo dei crediti per il pagamento dell’acconto di novembre, in quanto un blocco non rilevato potrebbe paralizzare l’intera operazione di versamento.
Sul versante del calcolo, una delle novità più impattanti deriva dalla maxi deduzione per le nuove assunzioni introdotta dal D.Lgs. n. 216/2023. La norma prevede che, ai fini della determinazione dell’acconto 2025 secondo il metodo storico, l’imposta 2024 debba essere ricalcolata come se l’agevolazione non fosse stata applicata. Il rigo “differenza” del modello Redditi 2025 non può quindi essere utilizzato senza rettifiche: occorre ricostruire l’imposta teorica del periodo precedente depurando l’effetto della super deduzione. Per chi opta per il metodo previsionale, la maxi deduzione può invece essere considerata nella stima dell’imposta del 2025, ma ciò comporta l’assunzione del rischio legato a un’eventuale insufficienza degli acconti.
Un’analoga attenzione è richiesta per l’applicazione della IRES premiale introdotta dalla legge di bilancio 2025. L’agevolazione riduce l’aliquota al 20% sugli utili 2024 destinati a riserva vincolata e poi reinvestiti, ma non ha effetto sulla base di calcolo degli acconti dei periodi successivi. Il legislatore ha infatti stabilito che, per la determinazione degli acconti relativi all’anno seguente, si debba assumere come imposta di riferimento quella calcolata applicando l’aliquota ordinaria del 24%. Ne consegue che la mini IRES non altera l’importo della seconda rata di acconto 2025 e che i suoi effetti si renderanno pienamente visibili solo a partire dagli acconti del 2026, nell’ambito della pianificazione fiscale complessiva dell’impresa.
Attenzione: Dal 1° luglio 2024 ogni F24 con compensazioni deve essere trasmesso tramite Entratel o Fisconline: l’inasprimento dei blocchi alle compensazioni — dai limiti quantitativi ai divieti in presenza di ruoli o carichi sospesi — rende indispensabile verificare la posizione debitoria prima di versare l’acconto, soprattutto alla luce degli effetti della maxi deduzione e della IRES premiale sulla base storica.
Il Concordato Preventivo Biennale e le scelte strategiche tra storico e previsionale
Un capitolo particolarmente articolato riguarda il Concordato Preventivo Biennale (CPB), che incide in modo diretto e sostanziale sulla determinazione degli acconti dovuti per i periodi coperti dall’accordo. L’adesione al CPB non comporta un superamento delle regole ordinarie sugli acconti, ma determina una modifica della base di riferimento, poiché il reddito o il valore della produzione concordati diventano l’elemento centrale per il calcolo dell’imposta dovuta. Si tratta di un passaggio non meramente formale, che richiede un allineamento puntuale fra risultati concordati, modelli dichiarativi e dinamiche di versamento.
Per i contribuenti che hanno aderito al biennio 2024–2025, il 2025 costituisce il secondo anno di applicazione: in questo caso, il sistema è più lineare, poiché l’acconto di novembre va determinato secondo le regole ordinarie, assumendo come base l’imposta 2024 derivante dal reddito concordato. Non si applicano invece le maggiorazioni del 10% sulle imposte dirette e del 3% sull’IRAP, previste dalla normativa esclusivamente per il primo anno di concordato. Il rigo “differenza” del modello Redditi 2025 contiene già l’effetto del reddito concordato depurato della componente eventualmente soggetta a imposta sostitutiva, e rappresenta quindi la base di partenza per il calcolo dell’acconto.
Per i contribuenti che hanno aderito al biennio 2025–2026, la situazione è più complessa perché il 2025 è il primo anno di CPB. In tale ipotesi, oltre all’acconto calcolato con le regole ordinarie, deve essere versata una specifica maggiorazione pari al 10% sull’imposta sui redditi e al 3% sull’IRAP, applicata alla differenza positiva tra il reddito o valore della produzione concordati per il 2025 e i corrispondenti valori del 2024 rettificati secondo le regole proprie del concordato. Tale maggiorazione va versata entro la scadenza del secondo o unico acconto tramite appositi codici tributo ed è destinata a essere scomputata in sede di saldo. Nei regimi di trasparenza fiscale, l’onere IRPEF connesso alla maggiorazione grava sui soci in proporzione alle quote; nel consolidato IRES, invece, è la controllante a dover effettuare il versamento considerando anche le maggiorazioni riferibili alle società consolidate che hanno aderito al CPB.
Per i contribuenti non aderenti al concordato, il sistema resta formalmente ordinario, ma offre margini operativi significativi. È infatti possibile combinare metodo storico e previsionale non solo tra imposte differenti, ma anche tra prima e seconda rata dell’acconto della stessa imposta.
Ciò consente di intervenire in corso d’anno per correggere scelte fatte al momento del primo acconto, adeguandole all’andamento aggiornato dell’esercizio. Tale flessibilità risulta particolarmente rilevante per i soggetti ISA, i forfettari e i contribuenti minimi, che versano l’acconto in due rate uguali e che devono costruire eventuali previsioni sulla base di stime meno strutturate, essendo privi di una contabilità ordinaria dettagliata. In questi casi, la scelta del metodo previsionale richiede prudenza, ma può risultare un utile strumento di ottimizzazione finanziaria.
Attenzione: Il Concordato Preventivo Biennale incide direttamente sulla misura dell’acconto: nel primo anno comporta una maggiorazione del 10% sulle imposte dirette e del 3% sull’IRAP, mentre nel secondo anno si applicano le regole ordinarie. La scelta tra metodo storico e previsionale diventa così strategica, soprattutto per valutare la convenienza dell’adesione e gestire correttamente gli effetti sui versamenti.
Considerazioni conclusive
La scadenza del 1° dicembre 2025 conferma che il sistema degli acconti non è solo un meccanismo di riscossione anticipata, ma una vera piattaforma di governance fiscale. Le novità normative — maxi deduzione, IRES premiale, CPB, limiti più rigidi alla compensazione — impongono al professionista un approccio strategico e non meramente esecutivo.
La scelta tra metodo storico e previsionale non riguarda solamente la massimizzazione della liquidità, ma diventa parte integrante della pianificazione del carico fiscale complessivo, influenzando scelte di investimento, gestione del personale, politiche di remunerazione dei soci e sostenibilità finanziaria.
La verifica preventiva della posizione debitoria e della disponibilità dei crediti utilizzabili in compensazione, il controllo degli effetti delle agevolazioni applicate nel 2024 e la previsione dell’imposta futura sono attività che richiedono un’analisi integrata, nella quale il commercialista assume il ruolo di regista fiscale dell’impresa.
La scadenza di novembre — lontana dall’essere un mero adempimento — diventa quindi l’occasione per misurare la qualità della pianificazione e per presidiare il rapporto tra contribuente e fisco in una fase dell’anno in cui le decisioni assumono un valore determinante.
di Roberto Bianchi
TAG Acconto Novembre 2025Pianificazione FiscaleVariabili normative